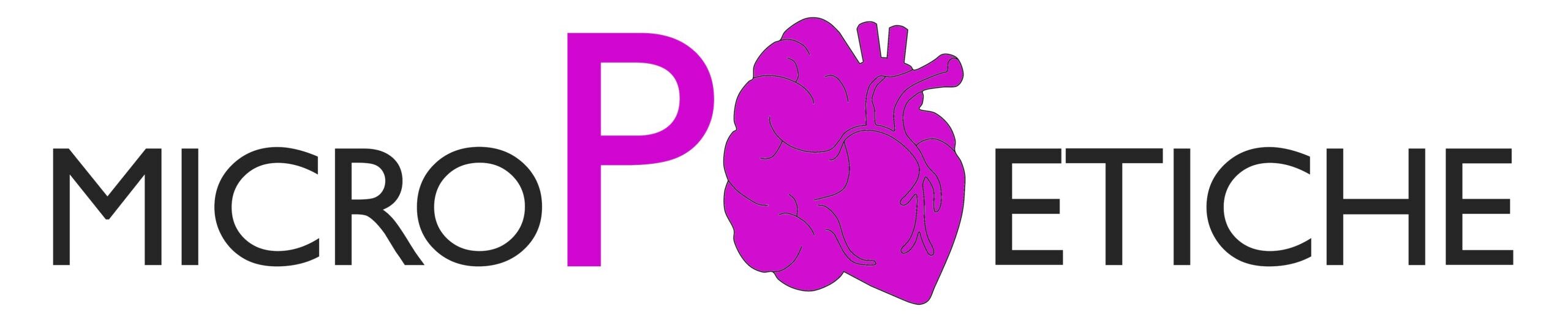La poesia nasce dalla realtà della nostra quotidianità. Emerge dai sommersi e lì rimane, in un’ansa di libertà, finché il poeta non la solleva e la genera alla luce. La poesia è la domanda alle domande, è l’ascolto di chi parla piano, è l’urlo di chi volta la faccia, è il canto soave per la testa dei bambini, la spina conficcata nella carne. Dilaga senza farsi vedere, si ritira alle richieste degli astanti, si insinua senza desiderare nulla. Con lei si può essere sinceri: lei non giudica, non dà consigli, non risolve i problemi. Sta e rimane inerme: viene attivata nel modo che solo ognuno conosce.
La poesia non segue le strade del volere. La poesia esige rispetto, coerenza, ardore. Il processo della poesia è uguale a quello che l’artista affronta con la materia ma essa è materia impalpabile che il poeta non può toccare con le mani ma solo con le spire dell’anima. Il processo generatore della poesia procede dall’esperienza del giorno, dagli affanni del passato, dalle prefigurazioni del presente. Il futuro appare lontano e in esso il poeta non riesce a riversare.
La poesia non attende, lei desidera e afferra per sé tutti i momenti più sacrali della vita. Li riconosce e, in quell’attimo, parla, sussurra, grida, squarcia, confonde, travolge. Dopo questo primigenio amplesso, il poeta può prenderla per mano e aspirare a renderla perfettibile, fermandosi quell’istante prima che lo diventi. Proprio nel costante essere nel fallimento, nella consapevolezza di non poter raggiungere il perfetto sta il meraviglioso della poesia, quell’afflato che corrisponde all’umano.
La poesia è eresia: eresia deriva dal greco αἱρέω «scegliere». Ecco perché la poesia è eresia, per la reciproca scelta che lei impone al poeta e che il poeta impone a lei. Allora noi, piccoli lettori di poesie, liberamente ci avviciniamo a lei o da lei ci allontaniamo.
«Ecco, io risiedo in questo gioco di forze e vivo e mi faccio vivere. Tutto appartiene a questo flusso, io vi navigo ogni giorno, ogni ora della vita.»